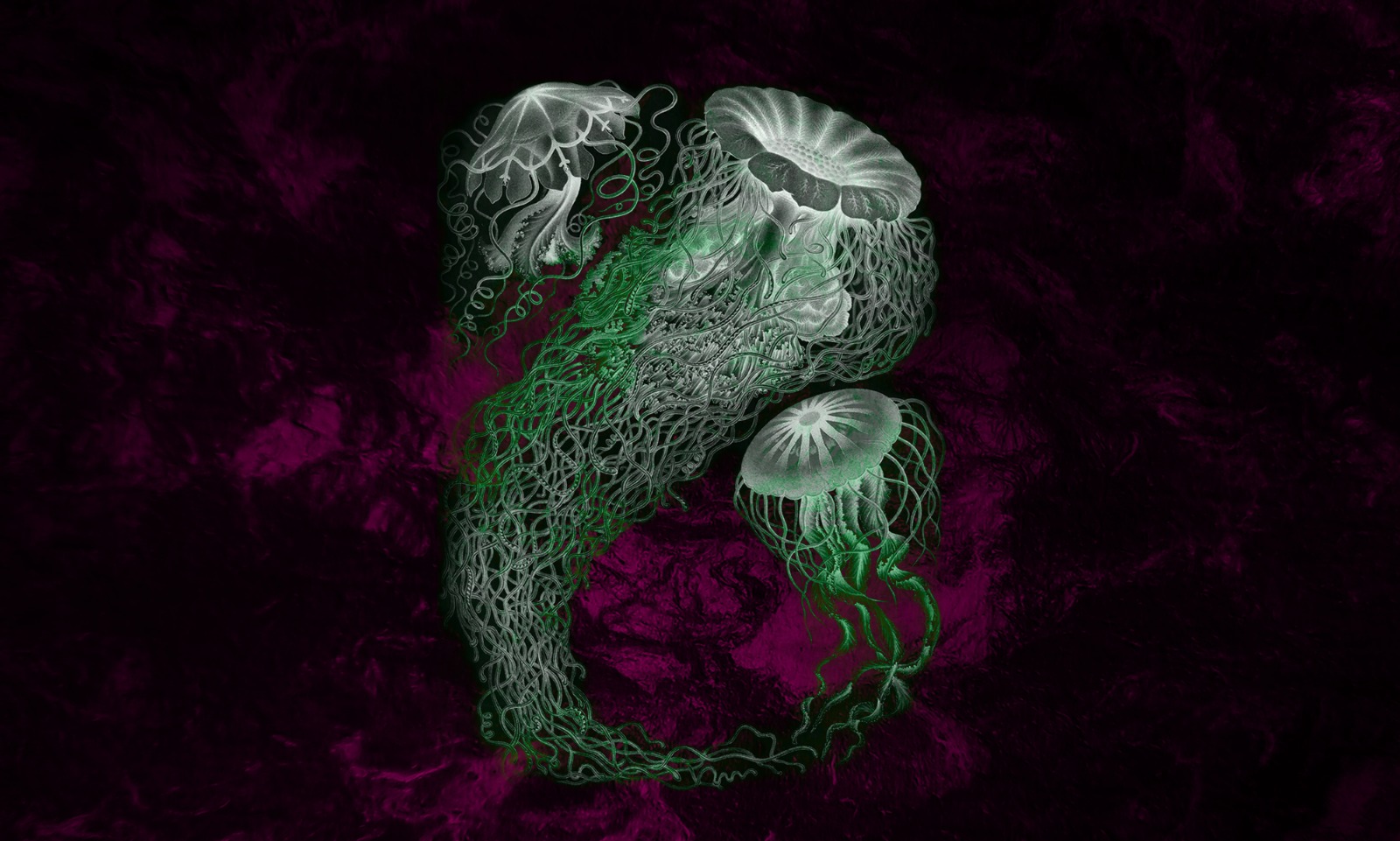Di fronte a dolore e macerie, riconoscimento dell’Altrə, responsabilizzazione e azione collettiva

In questi giorni, attonitɜ e impotenti, stiamo assistendo a un massacro in tempo reale, in diretta mediatica. L’uccisione di migliaia di persone intrappolate nella Striscia di Gaza, con bombardamenti massicci, anche al fosforo bianco. Un popolo lasciato senza acqua e cibo, senza elettricità e medicinali. Gli attacchi indiscriminati anche in Cisgiordania da parte dell’esercito e dei coloni israeliani. Un attacco che lascia intendere una volontà di sterminio e di annientamento della popolazione palestinese disumanizzata e resa nemica, con una retorica criminale e islamofoba che sovrappone gli abitanti di Gaza con il terrorismo di matrice islamica. Definirla una guerra è scorretto, dato che non si stanno affrontando due eserciti nazionali, ma siamo di fronte a un esercito rifornito di ogni tecnologia e armamento che sta attaccando un territorio privo di uno Stato autonomo e densamente popolato, distruggendo ospedali, campi profughi, scuole piene di civili indifesi con la scusa di colpire una organizzazione terroristica.
Come già scritto, lavorando nell’ambito della salute mentale e a contatto con la sofferenza delle persone che vivono esperienze traumatiche, siamo consapevoli dell’impatto di tutto ciò sull’esistenza. La soglia della sofferenza è oltre l’immaginabile e il rischio per chi assiste, al sicuro nelle proprie case lontane dalla Palestina, è che si ceda all’assuefazione di fronte all’orrore e al dolore altrui e che l’impossibilità di tollerare o anche solo immaginarsi questo dolore ci porti a difenderci, dissociandoci emotivamente.
La dissociazione è una funzione psichica della vita quotidiana, necessaria quando si tratta di compiere alcune funzioni, un modo per ridurre l’ansia in condizioni di stress o per distaccarsi da ciò che ci circonda per mantenere uno stato mentale piacevole e rilassato. Si divaga con la mente. È un meccanismo di difesa che permette di isolarsi dal mondo, concentrando i pensieri su qualcos’altro. Serve anche a proteggere dal dolore e dai ricordi spiacevoli, permettendo di continuare a vivere nonostante il dolore psichico esperito. Questo avviene grazie a una separazione di un’idea o di un ricordo dal suo significato emotivo e dall’affetto ad esso collegato.
Per reggere al violento impatto emotivo sulla nostra mente quando succede qualcosa di molto brutto e insopportabile si sperimenta un senso di distacco che ci porta a ridurre l’impatto emotivo dell’evento traumatico sulla nostra psiche.
Quando questa modalità diventa strutturale nella personalità di un soggetto e viene usata in modo massiccio e pervasivo per non entrare in contatto con parte della propria realtà psichica e parte di quella esterna, per negare ciò che sta succedendo facendoci sentire indifferenti o ostili alla verità, allora la dissociazione diventa patologica e dannosa. Succede ai singoli individui e sembra succedere anche a livello globale. La popolazione mondiale, grazie alla pervasività dei mezzi di comunicazione digitali, viene esposta in modo confusivo e passivo all’uccisione di migliaia di persone.
Molte persone stanno protestando per le strade di tutto il mondo e stanno affrontando il dolore di assistere indifesi a un genocidio ma tante altre sembrano negare le atrocità compiute dallo stato di Israele avvallate in modo criminale da istituzioni e governi.
Oltre alla dissociazione sappiamo, grazie alla psicoanalisi, che esiste un potente meccanismo della nostra mente, definito col termine diniego, che porta a un ritiro e a una fuga dalla consapevolezza di quello che succede fuori da noi, quando lo si vive con troppo dolore, o tende a contraddire le nostre convinzioni difensive. Ci si rifiuta di riconoscere una parte di realtà spiacevole, si fugge da essa, la si nega e la si sostituisce con dei fatti opposti, usando argomenti pragmatici e ‘razionali’. Le persone mettono in atto manovre elusive che evitano loro una messa in discussione e un’assunzione di responsabilità. Non ci si può mettere in discussione, e quindi affrontare la realtà e ammettere quello che accade, se si è convinte di non c’entrare nulla, che la responsabilità sia esterna e ciò che sta avvenendo sia causa di forza maggiore.
Vi sono aspetti della realtà, ed è quello che stanno vivendo milioni di esseri umani in questo momento, che risultano impensabili, che vanno cancellati per la paura e il terrore che possano toccare un giorno anche a noi.
Questo atteggiamento mentale generalizzato e onnipresente, utile all’individuo a sopravvivere psichicamente ogni giorno, usato a livello collettivo per negare un’atrocità in atto e per mantenere intatta la propria esistenza privilegiata, rispetto ad altre situazioni di oppressione, è ciò che ha consentito da sempre i genocidi, l’oppressione dei popoli e delle classi lavoratrici, il razzismo, le violenze del patriarcato, l’esistenza dei regimi fascisti e teocratici.
Essere pronti a scendere a compromessi, adattarsi allo stato di cose presente o sentirsi indifferenti diventano il supporto a tutto ciò. Nonostante ci siano prove tangibili, obiettive, visibili del massacro che sta avvenendo si preferisce non vedere o schierarsi dietro una presunta ragionevolezza. Si è convinti di basarsi sui fatti, su elementi razionali e oggettivi, mentre di fatto li si sta selezionando per sottrarsi alla vista di ciò che non si sopporta, che contraddice la propria convinzione comoda e privilegiata.
Questo funzionamento, pur permettendoci di adattarci in situazioni contraddittorie, sembra comportare una sensazione di alienazione e impotenza. Diventa necessario funzionare a colpi di scissioni e negazione, per sopportate contraddizioni talmente laceranti che fanno dubitare del senso di noi e del mondo. È una condizione che subiamo a causa del sistema in cui viviamo e che ci mette in contatto con l’aberrazione, che ci obbliga a comportarci in maniera contraria alle nostre convinzioni. L’unico modo per mettere insieme le cose diventa negare la realtà per liberarci della responsabilità delle nostre scelte e azioni. Dobbiamo mentire a noi stessɜ e al mondo per sopportare. E se ci troviamo dalla parte di chi opprime non possiamo che funzionare in maniera scissa.
Durante guerre e stermini, infatti, la modalità prevalente di pensiero non può che essere quella della scissione che porta a due rappresentazioni estreme della realtà, una parte buona e una cattiva.
La parte avversaria da distruggere sarà connotata da soli elementi negativi, mentre la propria parte assumerà un valore positivo assoluto e idealizzato. E si sarà pronti a tutto per portare avanti la propria parte.
La rabbia cieca e la violenza che stanno guidando gli atti criminali dell’esercito israeliano e del suo governo non sono altro che l’espressione di una rabbia narcisistica reattiva e distruttiva in cui l’Altro da sé, considerato il persecutore, è il nemico che non può che essere completamente annullato dalla faccia della terra. Quello che d’altronde Israele sostiene sia l’obiettivo del mondo arabo nei suoi confronti. La distruttività ha origini dalle ferite narcisistiche inflitte al sé e dal terrore che la propria esistenza sia messa in pericolo.
Questa furia senza pensiero, e quello che comporterà una volta che il ‘nemico’ sarà eliminato definitivamente, tornerà indietro come un boomerang a Israele e ai suoi cittadini. Il rifiuto da parte dell’occidente di riconoscere l’impatto del trauma dovuto all’occupazione dello Stato di Israele e delle sue truppe militari e colonie nei territori palestinesi, la violazione e l’origine traumatica e patologica che ha portato all’occupazione di quelle terre, è il grave errore che ci ha condotto fino a qui. Il rischio che in questo clima di odio e ottusità vi sia una recrudescenza razzista nei confronti degli ebrei in tutto il mondo è altissimo.
La guerra porta dietro di sé solo macerie, fa crollare l’orizzonte di senso. Essere sconfittɜ significa prima di tutto perdere la capacità di esprimere in parole il proprio dolore. Tutta la comunità regredisce, ricorre a scissioni rigide (noi-loro, buoni-cattivi) che diffondono paranoia, degenerazione etica e carenza di pensiero critico.
La tendenza a negare dignità e legittimità all’alterità dell’Altro da noi, a disumanizzarlo, è una tendenza possibile in ciascuno di noi. Lo sforzo che bisogna compiere è proprio quello di essere consapevoli che la nostra sicurezza in tempi oscuri deriva da un senso di appartenenza acritica e senza scarti al proprio gruppo. Questa adesione totale, però, può rendere ristretto lo spazio mentale e l’empatia verso chi rimane fuori da questo gruppo. Il gruppo, quando è in modalità maniacale e proiettiva, diventa incapace di pensiero.
Questa realtà che ci sta schiacciando e ci mette in difficoltà nell’elaborare aree cieche, inaccessibili alla consapevolezza, rende necessario un contesto relazionale per essere affrontata. Esattamente come avviene nel setting terapeutico, anche da un punto di vista collettivo, abbiamo bisogno di contesti di elaborazione grazie alla relazione, al confronto, al contatto con altre persone e con il loro punto di vista.
E ancor prima vengono il contatto con sé stessi e le proprie emozioni e il contatto con la realtà che percepiamo e da cui ha origine una verità. Una verità che può essere davvero sentita solo stando dentro le cose e l’esistente.
Questo aiuta a uscire dalla modalità di scissione, proiezione e negazione tipiche della posizione maniacale, paranoica, distruttiva e guerrafondaia che abbiamo visto assumere più e più volte nel corso della storia umana. Ricordiamoci che nessuno è immune a questo possibile funzionamento e quindi pur consapevoli dell’esistenza di una verità storica, anche quando sappiamo di essere dalla parte giusta, quella delle oppresse, bisogna mantenere questa attenzione alla riflessività e al confronto, all’apertura e alla sospensione del giudizio. Lasciare spazio al pensiero, al dubbio, al confronto con gli aspetti scomodi insiti nelle differenze e nei diversi posizionamenti. Sappiamo quanto la modalità di comunicazione ‘social’ sostenuta dagli algoritmi delle piattaforme commerciali lasci poca possibilità al pensiero riflessivo anzi, al contrario, sostiene la posizione schizoparanoide della scissione in buona e cattivo, della polarizzazione in vero e falso.
La consapevolezza di come funzioniamo ci può aiutare a contrastare tutto ciò. Ci difende dal meccanismo di proiezione sull’altro della crudeltà e dell’istinto di uccidere che poi è quello che porta a giustificare la propria crudeltà. Il trauma rende più inclini all’acting out (il soggetto mette in atto comportamenti spesso aggressivi e impulsivi per esprimere vissuti conflittuali e inesprimibili attraverso la parola e comunicabili solo attraverso l’agito, senza, in alcun modo, prendere in considerazione le possibili conseguenze del gesto) rispetto alla mentalizzazione e alla coscientizzazione.
Uscire da questo funzionamento scisso e proiettivo è estremamente difficile ma possibile.
Bisogna cercare di non farsi intossicare dai discorsi senza possibilità di appello. Lasciare spazio alla curiosità, a un libero pensiero critico e personale, all’ascolto di punti di vista diversi. Questo non ha niente a che vedere con la tendenza tutta ‘sinceramente democratica’ di accettare come interlocutori persone in mala fede, perché fascisti e provocatori, il cui unico obiettivo è quello di intossicare un possibile dibattito. Questo tipo di confronti, classici dei programmi televisivi italiani, non sono quelli di cui stiamo parlando e sono delle perdite di tempo, oltre ad essere delle manovre per legittimare gente razzista e fascista la cui bocca dovrebbe invece rimanere chiusa perché foriera di distruttività.
Quanto è importante trasformare il pensiero in azione? Può farci bene passare da una sovraproduzione di pensieri, considerazioni, riflessioni e dibattiti a una possibilità di agire conseguente, di mettere in atto ciò che pensiamo, di sentirci efficaci nella realtà, di incidere nel reale, non solo attraverso le parole ma in quello che sperimentiamo insieme ad altre persone, coi nostri corpi. È l’esperienza che si vive quando una comunità si ricompatta in seguito a degli eventi catastrofici e traumatici e che trova nella ricostruzione e nella riparazione una risposta fondamentale per recuperare un senso di potenza, una risposta che allieva il dolore. È sempre una risposta collettiva e corale. In questi momenti più che mai bisogna mantenere i legami, mantenere le relazioni che possano far sentire un senso comunitario ed evitare lo sfaldamento della trama psichica collettiva,In questo modo possiamo provare a contenere la sofferenza di ognunə di noi, grazie a una presa in carico e una ricostruzione. Perché esiste uno psichico collettivo e noi dobbiamo assumercene la cura, tanto quanto ci assumiamo la cura degli individui e dei piccoli gruppi. Dobbiamo provare a identificarci le une negli altri, sentirci parte di un ideale comune e soprattutto trovare una possibilità di riparazione.
Come Brigata Basaglia pensiamo che uno dei modi per rimanere in contatto con ciò che sta succedendo, e che ci fa sentire impotenti e rassegnatɜ, sia sentirci parte di una resistenza agita e partecipe, sentirci parte di una collettività che si oppone a quello che sta succedendo mettendo in campo anche i nostri corpi. Sia scendendo a protestare insieme ad altre migliaia di persone e facendo azioni dirette, sia creando spazi di incontro e confronto. Costruire contesti sociali che possano fornire un contenimento trasformativo delle esperienze. Parlando tra di noi, dando spazio al pensiero in opposizione ad una cieca violenza, ascoltando testimonianze e riportandole ad altri in una catena di condivisione e significazione. Farci testimoni attive del trauma all’interno e intorno a noi, trovare un modo per interrompere la catena della distruzione e della rabbia per evitare di ripetere questo orrore. Il ‘mai più questo’ è possibile solo se ci si assume la responsabilità della condivisione, dell’integrazione e della cura delle ferite del mondo. Mettere in parole l’orrore, accogliere e testimoniare ciò che le persone stanno soffrendo e contrastare i tentativi di sminuire e svalutare i racconti dei sopravvissuti, denunciando anche l’uso del principio identitario usato come giustificazione della spietatezza che non apre ad altre soluzioni se non la totale distruzione dell’Altro in nome della propria identità.
Le parole e i ragionamenti, come dovremmo ormai aver capito, non bastano e anzi, quando non sono seguiti da pratiche conseguenti, fanno sentire frustratɜ e inutili. È fondamentale mettere in gioco l’azione, insieme. Creare forme nuove di boicottaggio con l’obiettivo di sostenere e proteggere la popolazione, azioni dirette, non solo simboliche, e che vadano a buon fine. Appoggiamo l’importante iniziativa dei portuali di Genova che si sono rifiutati di caricare le navi con gli armamenti diretti a Israele e coi loro corpi hanno bloccato uno dei principali accessi al porto.
Sarebbe auspicabile creare un grande movimento di massa organizzato che possa raggiungere quei luoghi e andare a sostenere la popolazione con supporti materiali e psicologici, sostenere la loro resistenza e opporsi alla distruttività della guerra.
Dobbiamo contrastare la tendenza tutta umana di preferire non vedere e sentire ciò che fa male, cercando di non portare da solɜ questo peso enorme ma condividendolo e trasformandolo in una risposta costruttiva di responsabilità, resistenza e riparazione.