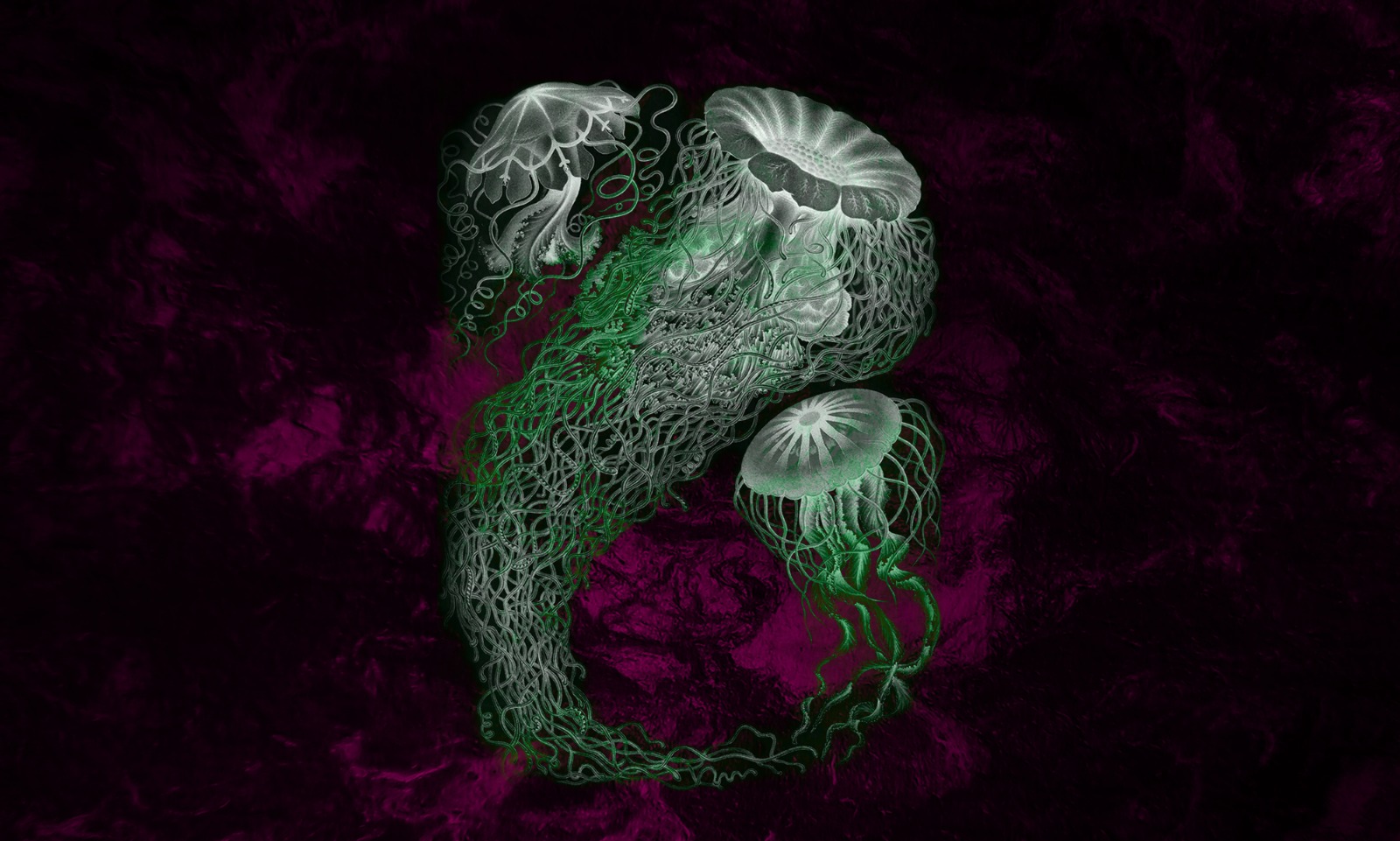di Sara Berardelli
Questo articolo parla di antispecismo e delle possibili correlazioni tra questo movimento e un approccio alla salute mentale non stigmatizzante, eccessivamente medicalizzante o individualista – approccio che come Brigata Basaglia condividiamo.
Per correttezza ci teniamo a precisare che il nostro collettivo non si definisce antispecista. Siamo però interessatə al tema e ad approfondire la visione di questo movimento, e quindi contentə di pubblicare questo contributo.
Buona lettura!

Giulia Cerioli (@cg.collages), collage su carta (2022)
Una breve introduzione all’antispecismo
L’antispecismo è una corrente di pensiero di matrice filosofica ma soprattutto un approccio politico che cerca di scardinare l’idea che esista una “naturale” gerarchia in termini di valore in base alla specie – umana o animale – di appartenenza.
La considerazione degli animali non umani come inferiori (in termini intellettivi, emotivi, di diritti ad essi dovuti ecc) rispetto agli animali umani [1] è spesso vista come scontata, ignorando le motivazioni culturali, economiche e psicologiche che hanno portato l’umanità a considerarsi e comportarsi come la specie dominante.
La tradizione specista è talmente insita in noi da tradursi in credenze e comportamenti spesso agiti senza consapevolezza, e non solo rispetto a ciò che mangiamo o indossiamo. Essa si radica in profondità, delineando una precisa idea del rapporto tra umano e animale, definendo quali sono i diritti da concedere, i compromessi da accettare e i limiti oltre i quali siamo o non siamo disposti a spingerci.
A decidere tutto ciò siamo sempre noi umani, secondo il nostro punto di vista e i nostri privilegi e ponendoci come soggetti che si relazionano ad animali-oggetti: delle nostre ideologie, scelte o inclinazioni.
La gerarchia che lo specismo determina non coinvolge solo le macro specie umana e animale ma si addentra tra le fila della seconda, decretando quali animali possono essere mangiati e quali utilizzati per la pelliccia, quali vanno considerati pericolosi, quali “domestici” e d’affezione e così via.
É utile premettere che l’antispecismo non coincide con le correnti animaliste, poiché queste mancano generalmente dello sguardo più ampio di cui esso si fa portavoce, intersecandosi ad altre lotte e cercando di criticare il rapporto dell’uomo con l’animale secondo diverse prospettive e sempre in ottica sociale e politica.
L’antispecismo cerca di scardinare ciò che è tanto familiare quanto invisibile e di ripensare il rapporto tra le specie in ottica di disparità di potere e oppressioni culturalmente determinate. Lotta contro lo sfruttamento, la capitalizzazione e l’annichilimento delle specie diverse da quella umana, facendosi promotore del diritto ad una vita priva di violenza, assoggettamento e coercizione, ma dignitosa e libera per tuttə.
Introdurre in poche battute le questioni nevralgiche su cui l’antispecismo si interroga non è semplice.
Si potrebbe cominciare ragionando sul linguaggio, che, come sempre, plasma ed è plasmato dal pensiero e dall’agire sociale. Ad esempio, potremmo riflettere su come ci riferiamo ad un animale come il cavallo, ovvero in base al suo utilizzo da parte dell’uomo. Nel nostro parlato è sempre un cavallo “da”. Da corsa, da tiro, da salto ostacoli, da macello, da compagnia, da monta, da carrozza, da fattoria didattica, da circo, da ippoterapia ecc. Questo vale chiaramente anche per altri animali, il discorso è sempre il medesimo: l’animale esiste ed è pensato solo in relazione all’uomo e alle funzioni che svolge per esso.
Il discorso sul linguaggio è estremamente vasto, poiché arriva ad intersecarsi con altre oppressioni, ad esempio quelle che coinvolgono le donne e/o le persone razzializzate. Lasciamo qui una suggestione e rimandiamo ad ulteriori approfondimenti questa tematica così complessa e illuminante.
“Le donne vengono sistematicamente animalizzate anche e soprattutto attraverso il linguaggio, specialmente per quanto riguarda il definire con un intento denigratorio la loro sessualità, sono quindi: porche, maiale, vacche, cagne, scrofe, troie (femmine del maiale), zoccole (femmine del topo). Vengono poi frequentemente appellate anche come galline, oche, vipere, balene, e così via. Una casualità?”. [2]
Per capire il posizionamento dell’antispecismo si può tornare alle sue differenze con l’animalismo, a cui siamo forse più abituati. Quest’ultimo si pone spesso in ottica salvifica e paternalista, guardando all’animale ferito, ucciso o offeso con sguardo pietoso, compassionevole, ancora “da”. In questo caso, da salvare.
L’antispecismo, invece, non nega totalmente l’intervento dell’uomo (che sarebbe in molti casi impensabile, almeno nella moderna società occidentale), ma ne auspica una sorta di mediazione e di supporto per garantire all’animale di autodeterminarsi.
Non guarda cioè all’animale come oggetto indifeso, ma come soggetto che, come noi, come tuttə, è sfruttato da uno specifico sistema che travalica i confini di specie.
Ciò significa dargli la possibilità di decidere per se stesso, di contemplare una libertà autentica, che lo svincoli dall’essere animale da e in relazione sempre e comunque all’umano.
Interessante a tal proposito la raccolta di storie di animali ribelli, in fuga da allevamenti, zoo, macelli, fattorie, laboratori, abitazioni ecc. proposta dal collettivo Resistenza Animale [3].
L’animale che evade, che travalica i confini dell’oppressione e si autodetermina, sostiene Marco Reggio nel suo testo “Cospirazione animale, tra azione diretta e intersezionalità”, rompe la narrazione dell’animalismo mainstream secondo cui siamo solo noi umani a lottare e prendere la parola per gli animali indifesi.
Qui gli animali si salvano, o almeno tentano di farlo, da soli, senza necessariamente l’intervento umano.
E a ben osservare, la ribellione animale tante volte assomiglia proprio a quella degli esseri umani, sia perché va contro a un sistema di dominio capitalista e comune a tutte le specie, sia perché ne condivide alcune pratiche e metodi come “la non collaborazione, il mutismo, l’autolesionismo, le aggressioni individuali, il rallentamento alla produzione, il movimento, il rifiuto del cibo, a volte fino a lasciarsi deperire.” [4]
Che queste fughe siano spesso fallimentari, non fa altro che riconfermare il dominio totalizzante dell’umanità sull’animale e sulla natura. L’animale in fuga, infatti, si ritrova in un ambiente a misura di essere umano, inospitale e inaccessibile, fatto di asfalto, macchine, traffico, rumori, mancanza di spazi liberi, divorati dalla proprietà privata e costellati da recinzioni. [5]
Resistenza Animale cataloga e dà valore a queste evasioni anche per contrapporsi alla narrazione che i media fanno su di esse, spesso tratteggiate con ironia folkloristica o considerate come eventi eccezionali, mettendo in dubbio l’intenzionalità di questi agiti. D’altro canto, sembra che queste sovversioni, per essere considerate valide, debbano essere interpretate dall’uomo, che irrimediabilmente e paternalisticamente deve parlare per colui che non ha voce, come se determinati agiti corporei non comunicassero di per sé e come se la parola fosse l’unico mezzo valido per esprimersi6.
L’oppressione animale ha tanti volti. Dalle atrocità subite negli allevamenti allo sfruttamento per piacere, divertimento o guadagno: le corse di cani e cavalli, gli zoo, i circhi, le sperimentazioni in laboratorio, i giri in carrozza nei centri delle città turistiche, l’equitazione, i canili, le fattorie didattiche, fino ad arrivare alle nostre case, dove conviviamo con animali che definiamo amici ma che in realtà sono quasi sempre mero oggetto dei nostri bisogni.
Di fronte a tutto questo le reazioni sono diverse, talvolta di indifferenza, ma spesso di negazione. Chi sostiene di “amare gli animali”, ma continua a cibarsene, a indossarli o a favorirne la vessazione in uno dei tanti modi possibili, deve trovare delle strategie cognitive ed emotive per convincersi di agire nel modo giusto.
Ad esempio, decidendo di mangiare solo carne di allevamenti biologici, bere il latte delle “mucche felici” che pascolano su grandi prati verdi ma, alla fine di tutto, vengono comunque forzate alla procreazione, private dei loro cuccioli (i cui maschi verranno uccisi), derubate del loro latte, scartate quando non più utili. Perché l’animale che non è produttivo, che è malato, vecchio, che non è più prestante (non solo gli animali “da carne”, ma ad esempio i cavalli impiegati nelle competizioni sportive), è da buttare.
Ciò che succede invece quando ci troviamo a mangiare animali è di vivere una dissonanza cognitiva ed emotiva per cui quella parte (la carne) non è riferita al tutto (l’animale un tempo vivo e ora cadavere).
E come sostiene Angela Davis “Il fatto che siamo in grado di sederci e mangiare un pezzo di pollo senza pensare alle condizioni orrende in cui i polli sono allevati industrialmente in questo paese è un indicatore dei pericoli del capitalismo, di come il capitalismo ha colonizzato le nostre menti. Il fatto che non guardiamo oltre il prodotto in sé, che rifiutiamo di comprendere le relazioni che sottostanno alle merci che usiamo quotidianamente. E così anche per il cibo”. [7]
Intersezioni con altre lotte
Questo collegamento con la produttività ad ogni costo non può che far risuonare echi che arrivano da altri contesti.
Come si diceva all’inizio, l’antispecismo è una posizione politica che si dichiara contraria allo sfruttamento della disparità di potere in ottica di sottomissione del più debole e per questo non può prescindere dall’intersezione con altre lotte alle oppressioni. Criticare le disuguaglianze tra animali umani e animali non umani conduce a dei parallelismi inevitabili con il femminismo, l’abilismo, il razzismo e in generale con le storie delle minoranze. Da un lato considerate inferiori, da salvare, sfruttare, invisibilizzare e infantilizzare e, dall’altro, osservate con sguardo rabbioso o impaurito.
Non è un caso, infatti, che anche alcuni esseri umani marginalizzati, considerati “diversi” dalla norma o appartenenti a minoranze vengano appellati e trattati come animali (ovvero come lo specismo intende e decide di opprimere gli animali non umani). “L’animalità, quindi, come sinonimo di alterità per eccellenza, categoria politica che contrassegna chiunque si allontani o sia al confine con l’Umano modello, diventando di conseguenza sacrificabile, maggiormente mortale e indegno di lutto”. [8]
E così, “un corpo umano che si sposta su una sedia a rotelle, un soggetto umano autistico o una mucca in fuga dal mattatoio sono altrettanto fuori posto”. [9]
Tornando ai sopra citati episodi di animali in fuga che si ritrovano in ambienti urbani inaccessibili e che rendono impossibile una vita libera dall’uomo, l’intersezione con l’abilismo si fa limpida. Quegli spazi urbani ed extraurbani sono sì a misura d’uomo, e non di animale, ma nemmeno di un essere umano qualunque, ma di uno specifico tipo di uomo abile e neurotipico.
Basti pensare agli spuntoni che impediscono ai senza tetto di stendersi sulle panchine, analoghi a quelli che, sui nostri balconi, tengono lontani i piccioni.
Se si guarda alla disabilità (come all’animalità) come un fatto sociale, ci si rende conto di come le persone siano disabilizzate non tanto dalla loro condizione psico-fisica, ma da come la società in cui vivono si rivolge ad essa, non riuscendo a creare spazi, contesti, interazioni e modi di vivere adatti per tuttə [10].
Un filo rosso tra canili e manicomi, tra l’antispecismo e Basaglia
Arrivatə fino a qui si può comprendere come una lotta politica alle oppressioni non possa prescindere dal coinvolgere tutte le specie.
A proposito di questo, un’intersezione interessante che come Brigata Basaglia ci coinvolge da vicino è quella tra l’antispecismo e l’antipsichiatria, o comunque con quelle visioni non stigmatizzanti, eccessivamente medicalizzanti e individualistiche della salute mentale, che rendono meno rigido e dicotomico il binomio salute-malattia.
Per cominciare questa complessa esplorazione di cui si daranno qui solo alcuni spunti, faccio un veloce viaggio indietro nel tempo.
Sono in prima media e la mia grande passione, da sempre, sono i cavalli e l’equitazione. Qualcosa, però, già a quell’età, non mi torna. Negli anni che ho passato tra diversi maneggi, ho osservato con una stretta al petto fiaccature sulla pancia dei cavalli date dagli speroni, strattoni, frustate, morsi in bocca. Animali che in natura vivrebbero in branco, a brucare tutto il giorno, costretti all’isolamento, rinchiusi in box di pochi metri per 365 giorni all’anno. Dopo una lunga ricerca trovo un maneggio che mi piace, dove le cose sembrano un po’ diverse, ma in realtà sono sempre le stesse. Noto che ancora una volta i cavalli considerati più problematici, difficili, indomabili, che mordono, non ascoltano, scalciano e disarcionano, sono sempre appellati in questi modi senza minimamente considerare la vita monotona, snaturata e di sfruttamento a cui sono sottoposti. E anche quei cavalli “cattivi” o “matti”, quando arriva l’estate e (se hanno fortuna!) dal box vengono spostati nel recinto esterno, con più libertà di movimento e di interazione con i loro vicini, improvvisamente si fanno più mansueti. Non è allora il contesto e lo stile di vita a cui li obblighiamo a farli, giustamente, impazzire?
Ed ecco una prima analogia con una visione della salute mentale che tenga in considerazione gli aspetti sociali e strutturali che conducono o contribuiscono a vissuti di disagio psichico.
In questo scenario l’animale, come chi è consideratə “folle”, diventano oggetto dei provvedimenti nel primo caso, delle cure del secondo, da parte dello stesso meccanismo di potere che potrebbe aver causato o accentuato la loro sofferenza. A entrambi viene privata l’agency, poiché c’è qualcuno (l’essere umano “sano”) a decidere sempre e paternalisticamente cosa sia meglio per loro.
Questo anche perché l’animale viene tipicamente considerato irrazionale, privo di quella ragione che contraddistingue l’essere umano e che gli ha permesso di imporsi come specie dominante.
In un universo sociale che si basa sul pensiero scientifico e razionale, anche per quanto riguarda i costrutti e la gestione di salute e malattia, l’animale e il “folle” possono essere facilmente relegati a un gradino di inferiorità, proprio in base a questa loro presunta insensatezza.
E così, l’animale non umano talvolta viene psichiatrizzato, e, parallelamente, l’umano non conforme alle norme sociali viene animalizzato (e di conseguenza deumanizzato), in modo da renderne più giustificato l’assoggettamento [11].
Un esempio calzante che intreccia questi diversi livelli di analisi è quello dei cani randagi, affrontato nel brillantissimo saggio “Chiudiamo i canili” di Troglodita Tribe, che scardina la prassi secondo cui un cane randagio va preso e portato “al sicuro” in canile, poiché sicuramente non saprà badare a se stesso o sarà pericoloso per l’uomo.
Così una persona che soffre va per forza presa in carico da un professionista e curata in maniera standardizzata e spesso più secondo i bisogni del curante che non di chi è curato.
Nel breve testo viene raccontata l’evoluzione della storia e del concetto di cane randagio nella società occidentale. Lə autorə sottolineano come nel nostro immaginario questi animali debbano per forza trovare una collocazione “umanizzata” e sia impossibile pensarli come liberi, per diversi motivi: perché si pensa di doverli salvare, di doverli rinchiudere in quanto pericolosi, malati, sporchi, perché possono esistere solo se oggetto e proprietà di qualcuno – un padrone, e già il termine ci dice qualcosa – e non senza quel prefisso da di cui si parlava all’inizio.
Sebbene sia difficile contemplare un cane senza proprietario, senza recinzione e senza vincoli, magari anche per un’autentica preoccupazione nei suoi confronti, i tre quarti dei cani del mondo vivono in uno stato di semi o totale libertà rispetto all’umano [12].
La provocazione del collettivo di chiudere i canili è così assoluta da sembrare sconvolgente, tuttavia non è da intendersi come lasciare liberi di autodeterminarsi tutti i cani in tutte le circostanze (ad esempio di abbandono, di malattia, di vecchiaia, in insediamenti urbani invivibili per loro ecc), ma di mettere in discussione ciò che facciamo perché semplicemente si è sempre fatto così e cercare delle alternative.
Una provocazione che cerca di cambiare la nostra idea stereotipata di cane, pet da coccolare, che deve riportare la pallina, rispondere agli ordini, comportarsi bene, non tirare al guinzaglio, scodinzolare quando torniamo a casa. Un giocattolino da infantilizzare, da trattare come un “figlio”. Ma i figli non si strattonano e si tengono al guinzaglio, vanno lasciati liberi di individuarsi e diventare se stessi.
Anche quando pensiamo di amare il nostro cane o gatto, di garantirgli una vita di comfort, riflettiamo se è davvero un suo bisogno o se è quello a cui noi ogni giorno lo abbiamo fatto piegare per rispondere ai nostri desideri e necessità.
Chiudere i canili, quindi, prima che un’azione concreta, è un’operazione mentale per cambiare la nostra prospettiva e attitudine rispetto a questi cani “compagni” (o servi) dell’uomo da secoli.
Così come chiudere i manicomi non è bastato, poiché serve costantemente rivedere la nostra idea di malattia e salute mentale, adottando uno sguardo non giudicante, che sappia mettersi costantemente in discussione, che non si acconti di una diagnosi, che non guardi alla sofferenza come qualcosa di universale e dalle cause solo individuali, ma complesso, cangiante, sociale e culturale.
In generale, ciò che lə autorə affermano con risolutezza è che la soluzione al randagismo non può essere il canile-prigione, dove i cani sviluppano depressione e ansia, dove vivono isolati dagli altri, senza valvole di sfogo, senza poter scavare, correre, annusare, giocare.
Dove la vita che “viene salvata”, ancora una volta, col paternalismo di chi sa cos’è meglio per l’altrə, in realtà viene appiattita e ridotta alla mera sopravvivenza.
Il paradigma della salvezza si muove in questa direzione: con l’obiettivo di evitare pericoli e sofferenze, si finisce per impedire alla persona o all’animale di vivere un’esistenza libera e almeno in buona parte autodeterminata.
I cani, come coloro che soffrono di disturbi psichici, vengono sedati, calmati, resi conformi a come la società vuole che siano, anche attraverso l’utilizzo di farmaci.
E come prima della legge Basaglia, quando alla proposta di chiudere i manicomi emergeva la domanda di dove mettere poi i “matti”, si potrebbe riproporre lo stesso timore rispetto all’eventuale chiusura del canile.
Emerge così la suggestiva e terribile similitudine coi manicomi, con l’idea del “folle da salvare”, ma in realtà, da rinchiudere e da cui salvarci, della reclusione che non cura, ma mortifica e anzi acuisce l’eventuale patologia.
Ma non solo dei manicomi fatti di mura, bensì di quei dispositivi manicomiali che abbiamo nelle nostre menti, talmente interiorizzati da sembrare naturali e incontrovertibili.
Al di là delle forme più estreme di controllo (sui “folli”, ma anche sugli animali) vi sono infatti strumenti e modalità più sottili e quotidiane, difficili da individuare e sradicare, che contribuiscono ad annullare la soggettività di queste persone, ad escluderle dalla vita sociale, giorno dopo giorno [13]. E, d’altro canto, vi è la tendenza all’eccessiva psichiatrizzazione della sofferenza mentale, con conseguente abuso dell’utilizzo di farmaci.
Come raccontano Peluso e Regoli [14], anche il discorso sugli psicofarmaci può essere allargato dai contesti psichiatrici a quelli animali.
Questi ultimi, infatti, oltre ad essere stati oggetto delle sperimentazioni per gli psicofarmaci da somministrare agli umani, ne sono divenuti nel XX secolo veri e propri fruitori.
Da animale a paziente, ancora una volta per sottostare a quelli che le autrici chiamano “codici comportamentali antropocentrici”, per essere addomesticato e per far fronte a problematiche nate proprio a causa dell’intervento umano.
Negli allevamenti, come negli zoo e nei canili, ma anche nelle nostre case, gli animali non umani sviluppano disturbi simili a chi è considerato “folle”, come sintomi depressivi e ansiosi e mettono in atto azioni violente, di automutilazione o movimenti ossessivi e ripetitivi, soprattutto se tenuti in gabbia [15].
E questi vissuti si trasformano in patologie conseguentemente all’introduzione sul mercato di uno specifico psicofarmaco.
Ad esempio, meno di vent’anni fa “l’azienda Eli Lilly ha lanciato il Reconcile, farmaco chimicamente identico al Prozac, ma al gusto di manzo, masticabile e chimicamente approvato dalla FDA per il trattamento dell’ansia da separazione nei cani; contemporaneamente sono stati resi noti i risultati di uno studio finanziato dalla stessa Eli Lilly secondo cui il 17% dei cani statunitensi soffrirebbe di ansia da separazione”.
Un episodio emblematico di come gli psicofarmaci vengano somministrati ad un animale non per garantirgli maggior benessere “ma per impedirgli di esprimere il suo dissenso” è quello del gorilla Willie B. Le autrici raccontano di come questo gorilla, dopo la cattura negli anni ‘60, era stato recluso nello zoo di Atlanta per quasi 40 anni finché “un giorno ruppe il vetro di una delle finestre del suo recinto, per cui venne trasferito in una gabbia molto più piccola per sei mesi, mentre il vetro veniva sostituito. Il personale veterinario decise di tranquillizzarlo sciogliendo del Thorazine nella Coca-Cola che beveva tutte le mattine. […] Fu proprio una delle veterinarie dello zoo a comparare Willie, che vagava con gli occhi spenti nella sua gabbia, a un personaggio di un film ambientato in un ospedale psichiatrico” [16].
Cercando di unire i punti di questo discorso complesso e multiforme, chi è considerato “folle”, i cani randagi e gli animali in fuga raccontati da Resistenza Animale, non sono accettati perché sovvertono l’ordine sociale, sono considerati diversi, devianti, da rendere docili, addomesticati e, di conseguenza, non più pericolosi.
Al contrario, la visione che abbracciamo come Brigata Basaglia mette in discussione il concetto di normalità e cerca di dare valore e credibilità anche a ciò che in qualche modo si allontana dalla concezione della realtà comunemente condivisa.
Come si diceva all’inizio, l’antispecismo non mira a salvare l’animale, ma aiutarlo a salvarsi in un universo fatto di umani e di asfalto.
L’intento non è dunque di sostituirsi ad esso o rappresentarlo, quanto di permettergli di esprimersi.
Analogamente, come sostiene Bucalo nell’interessante discussione alla Festa Antispecista del 2016 [17], bisogna garantire ai “folli” il loro diritto ad essere insensati, anche perchè lo sono secondo “noi sani” e non in assoluto.
In un mondo dominato da una precisa idea di “normalità”, dobbiamo dunque sostenere la libertà di esistere in modi differenti, superare la visione dell’altrə (animale o umano) in ottica antropocentrica e normocentrica e ampliare gli orizzonti.
Chiudere i canili (come è stato fatto per i manicomi), e in generale porsi in ottica antispecista, potrebbe essere considerato estremo o insostenibile.
Eppure, queste visioni possono e devono adeguarsi alla realtà in cui viviamo, considerando modi nuovi di convivere come comunità interspecie, consapevoli di non poter essere totalmente indipendenti gli uni dagli altri, ma nemmeno estremamente dipendenti.
Come suggerisce Reggio, infatti, dobbiamo pensare e pensarci in ottica di interdipendenza e di sostegno reciproco, sia quando si parla di animali che di “folli”, ma, a ben vedere, di ognunə di noi.
NOTE
[1] Si userà spesso l’accezione “animali non umani” e “animali umani” per sottolineare il carattere di costruzione sociale delle categorie animale-umano, svelando la labilità del confine tra l’una e l’altra e l’utilizzo che ne viene fatto per giustificare e perpetuare l’oppressione di chi appartiene ai “non umani”. E, come si vedrà più avanti, di questo gruppo non fanno parte solo gli animali propriamente detti, bensì anche alcune persone marginalizzate, come chi soffre di disturbi psichiatrici.
[2], [8] Citazione dalla fanzine di Giulia Scotti Cerioli “Il femminismo sarà antispecista o non sarà”. Se interessatə a ricevere la fanzine in pdf scrivere all’autrice su IG > @cg.collages
[3] Per approfondire le storie di animali in fuga visitare il blog: https://resistenzanimale.noblogs.org/storie-di-rivolta/
[4], [5], [6], [9], [15] Reggio, M. (2022). Cospirazione animale. Tra azione diretta e intersezionalità. Milano: Meltemi Editore.
[7] Davis, A. citata in Reggio, M. (2022). Cospirazione animale. Tra azione diretta e intersezionalità. Milano: Meltemi Editore.
[10] Si rimanda al testo di Sunaura Taylor “Bestie da Soma” per approfondire la riflessione sulle intersezioni tra abilismo e antispecismo
[11], [14], [16] Peluso F. & Regoli G. (2023), L’animalizzazione tra antispecismo e antipsichiatria. Articolo pubblicato su Liberazioni n. 55
[12] Troglodita Tribe (2021). Chiudiamo i canili! Aprilia: Ortica Editrice. [13]. [17] Dal discorso di Bucalo “Sentire le voci: antipsichiatria e resistenza animale–Festa Antispecista 2016”. Per approfondire, il video integrale della discussione > https://www.youtube.com/watch?v=MedBPPTBYl0
Fonti:
Peluso F. & Regoli G. (2023), L’animalizzazione tra antispecismo e antipsichiatria. Articolo pubblicato su Liberazioni n. 55
Reggio, M. (2022). Cospirazione animale. Tra azione diretta e intersezionalità. Milano: Meltemi Editore.
Scotti Cerioli, G. Il femminismo intersezionale sarà antispecista o non sarà. Se interessati ad avere la fanzine scrivere all’autrice @cg.collages su Instagram
Taylor, S. (2021). Bestie da soma. Disabilità e liberazione animale. A cura di feminoska e M. Reggio, trad. it. di feminoska. Milano: Edizioni degli Animali.
Troglodita Tribe (2021). Chiudiamo i canili! Aprilia: Ortica Editrice.
Oltre la specie. Sentire le voci: antipsichiatria e resistenza animale-Festa Antispecista 2016. Video, 29 settembre 2016. https://www.youtube.com/watch?v=MedBPPTBYl0
Essere Animali. Introduzione all’antispecismo con il filosofo Gianfranco Mormino. Video, 27 gennaio 2023. https://www.youtube.com/watch?v=vO1GLY_QfjI